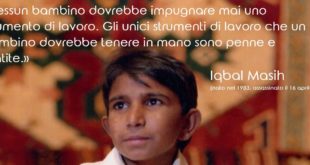La letteratura delle donne: Grazia Deledda
Grazia Maria Cosima Damiana Deledda
Grazia Maria Cosima Damiana Deledda nacque a Nuoro il 27 settembre 1871 da Giovanni Antonio Deledda e da Francesca Cambosu, quinta di sette tra figli e figlie.
Il padre (noto anche come Totoni), pur avendo conseguito la laurea in legge, non esercitò mai in ambito legale ma fu imprenditore e benestante possidente agricolo, culturalmente e politicamente attivo: appassionato di poesia e compositore di versi dialettali di cui faceva sfoggio nelle gare di stornelli e poesia estemporanea tipici della cultura paesana sarda, aveva fondato una tipografia in cui stampava una rivista e fu sindaco di Nuoro nel 1892. La madre, iconica figura femminile sarda di quei tempi, parlava in dialetto e vestiva sempre in abiti tradizionali.
Frequentò la scuola elementare solo fino alla classe quarta, come era del resto costume diffuso per le bambine di quei tempi non solo in Sardegna ma in quasi tutto il resto d’Italia all’indomani dell’unificazione nazionale. Terminato il percorso scolastico d’uso, Grazia Deledda venne istruita privatamente da un professore con lezioni di italiano, latino e francese, ma fu da autodidatta che come persona e scrittrice più ebbe modo di evolvere. Nel recinto dei limiti più o meno imposti trovò la forza di andare oltre quei limiti medesimi: si diede prestissimo alle due grandi passioni del leggere e dello scrivere, che le permettevano di evadere con il pensiero dal chiuso mondo della sua casa patriarcale e della città di provincia in cui viveva, periferica e doppiamente isolata perché nel cuore della Sardegna.

Incominciò giovanissima a pubblicare novelle (le prime su giornali sardi) e poi romanzi. Nel 1895 uscì il romanzo Anime oneste, che ottenne un successo di critica. Passava intanto a letture di autori quali gli scrittori realisti e naturalisti francesi e i grandi romanzieri russi.
Conosciuto a Cagliari, l’11 gennaio del 1900 sposa a Nuoro Palmiro Madesani, originario del mantovano e impiegato dell’Intendenza di Finanza: fu l’occasione di lasciare la Sardegna e muovere verso Roma, dove poco dopo il matrimonio il marito fu trasferito.
Sempre nel 1900 uscì a puntate nella “Nuova Antologia” Elias Portolu (pubblicato in volume nel 1903), romanzo caratterizzato da un originale impianto narrativo e che ebbe successo e fama internazionale grazie alla traduzione del francese Georges Herelle, uomo di ampia cultura e apprezzato traduttore di Gabriele D’Annunzio , Antonio Fogazzaro et Matilde Serao. A Roma trovò la dimensione aperta che la Sardegna negava: nella capitale italiana ebbe modo di conosce un fermento culturale di straordinaria ricchezza, crocevia di scrittori, critici, letterati ed editori. Ebbe modo di prender parte a dibattiti letterari, di confrontarsi con altri autori di fama italiana o già internazionale o che da lì a poco avrebbero ottenuto fama oltreconfine. Eppure lo spazio della persona Deledda rimase lontana dalla mondanità: la sua vita trascorse riservata e spesa tra la cura dei figli, Sardus e Franz, e la prolifica produzione letteraria. Più grande, più ricca di fermenti fu dunque la vita a Roma eppure un ennesimo stare ritirata, non forzato, in cui sarà eccezione nel maggio 1910 il viaggio a Parigi, oltre i rientri nel mantovano e in Sardegna.
Nel 1926 ottenne il premio nobel per la letteratura.
Della sua ricchissima produzione di narrativa fanno parte romanzi e raccolte di novelle. Tra i romanzi ricordiamo: Elias Portolu (1903), Cenere (1904), L’edera (1908), Canne al vento (1913), Marianna Sirca (1915), Cosima (uscito postumo, nel 1937, autobiografico).
Morì a Roma il 15 agosto 1936.
Sardegna, evasione ed emancipazione: i loro significati in Grazia Deledda

Quando si parla di ostilità intellettuale ambientale verso chi, come Grazia Deledda, era portatrice di istanze ben lontane dal quotidiano femminile e sociale dell’epoca e ancor più della Sardegna dell’epoca, occorre dare il giusto peso al tutto, contestualizzando non solo su un piano temporale ma anche personale e individuale. Questo senso di disallineamento tra cultura diffusamente condivisa in un’epoca e pulsione del singolo è il quotidiano storico dell’evoluzione sociale, l’insieme dialettico di istanze che sono la piattaforma da cui si dipana questo percorso di crescita, il più delle volte di un singolo e con esito sfortunato o, più raramente ma in maniera epocale, con la vittoria del singolo per antonomasia o di un gruppo che diventa simbolo di vittoria per una generazione e da lì in poi.
Grazia Deledda non era eroina di rottura e rivoluzione, non voleva probabilmente esserlo se non nella misura in cui il contesto non era adeguato alle sue ispirazioni. Nessuna volontà di mutamento di un sistema tradizionale ma una necessità di non essere schiacciata dal medesimo, semmai una lotta di riaffermazione anche della tradizione e della memoria antropologica secondo figure e metodi più moderni.
Se nelle sue opere l’ineluttabile era un fondamentale protagonista, così come il senso di peccato originale, di colpa, di schemi non solo sociali ma arcaico-antropologici, di fatto nel suo voler scrivere di quel mondo ne portava rispetto, il rispetto che era di chi cercava di darsi spazio senza distruggere oltre la misura dell’obiettivo quello spazio medesimo, come un ulivo si apre radici e spazi tra i graniti della Sardegna.
Trasformare ma non rivoluzionare, adeguare ma in modo arricchente, in aggiunta, senza perdere il senso delle proprie radici.

Non è difficile ritrovare una sorta di ambiguità in questa filosofia di fondo davanti ai nostri occhi, ma l’ambiguità è anche figlia di un modo contemporaneo di giudicare non poco manicheo, tipica risultante di una emancipazione – fortunatamente – che ha preso forma e coscienza, anche se ancora non certo completa, e che con le sue nuove sensibilità e metriche vede con sospetto a ritroso chi alla fine ha dato un posto a sé in quel contesto e non è diventata alfiere di un movimento o non si è prefissata mai davvero di esserlo.
In una delle tante lettere nella corrispondenza tra lei e Angelo De Gubernatis, nel 21 maggio 1893 scriveva [in grassetto quanto è da rimarcare come espressione emblematica]
Mio illustre e gentile amico.
Dunque, giacché i grandi sardi sono sconfortati e nessuno di essi vuol mettersi a capo di questa impresa, io stessa mi pongo in testa
a questo esercito che comincia a muoversi. E spero. Sono piccina piccina, sa, sono piccola anche in confronto delle donne sarde che sono piccolissime, ma sono ardita e coraggiosa come un gigante e non temo le battaglie intellettuali. Ora mi son messa in questa e spero di vincerla. In Sardegna sono molto conosciuta ed amata, specialmente dai giovani. Ora io ho fatto l’appello ad essi e son sicura che tutti mi risponderanno, non tanto per amor di patria quanto per amor mio.
È troppo poca modestia dir queste cose, ma io non conosco la falsa modestia e in arte non ci deve esser modestia per chi vuol farsi avanti.
Le mando la “Vita Sarda” ove c’è il mio appello, che verrà man mano pubblicato anche negli altri giornali dell’isola. Hanno già risposto da Alghero, Oristano, Bosa ed Ogliastra. Comprendo che bisogna sopratutto costituire la Società, ed anche a procurare soci mi sforzerò. Mi mandi un’altra diecina di programmi.
Mentre io scrivo queste righe e rispondo ad una lettera di Cagliari che riguarda questo affare, mia sorellina copia il nome dei principali
comuni sardi per mandarne la nota a Lei.
Lei può mandare il programma ai segretari comunali, quasi tutti giovani intelligenti e infarinati di letteratura, e molti, io credo, si associeranno. In questi giorni in tutta l’isola non si parla che di folk-lore e a poco a poco vengono su dei folk-loristi finora sconosciuti,
che lavoravano in silenzio e per conto loro. Tutto fa sperare, ed io farò tutto il possibile per riuscire.
Lei mi parla già di premio; ma io le dico che il mio miglior premio sarà la stessa riuscita, senza altro.
Il senso di femminile che è in Grazia Deledda è allo stesso tempo individuale e funzionale, come il solista per un coro: un senso di lotta al femminile e non di lotta per un’emancipazione femminile tout court e con tutte le contraddizioni del caso. Rappresentativi di questa tensione, ecco cosa scrive lei stessa nella lettera indirizzata a (Stanislao) Stanis Manca il 1° agosto 1891:
«…Io non sogno la gloria per un sentimento di vanità e di egoismo, ma perché amo intensamente il mio paese e sogno un giorno di poter irradiare con un mite raggio le foschie ombrose dei nostri boschi; narrare, intera, la vita e le passioni del mio popolo, così diverso dagli altri, così vilipeso e dimenticato e perciò più misero nella sua fiera e primitiva ignoranza…Mi si può dire che la gloria è una spaventevole cosa: si può sorridere della temerità della mia stolta fissazione, si può pensare ch’è al di sopra delle mie forze il còmpito che mi impongo: che non riuscirò mai a raggiungere la mia mèta; che non spetta ad una povera e umile fanciulla senza istruzione e senza appoggi di rialzare il nome di un paese; si rida di tutto ciò come rido io stessa nelle ore della realtà, quando facendo il mio esame di coscienza penso che la mia idea è una presunzione bella e buona; ma non si può dire che la mia anima deve restare una landa arida e deserta, benché illuminata dal sole dell’arte splendente .
[…] … in una donna della mia indole, molto pacifica ed inclinata alla tristezza…
…benché io sia una oscura e democratica ragazza…». (Lettera di Grazia Deledda a Stanis Manca, Nuoro, 1° agosto 1891; in Anna Folli (a cura di-), Amore lontano: lettere al gigante biondo, 1891-1909, Milano, Feltrinelli, 2010, pagg. 72-75)
E poi ancora, a Epaminonda Provaglio il 23 febbraio 1892
«[…] Figurati tu una ragazza che rimane mesi interi senza uscire di casa; settimane e settimane senza parlare ad anima che non sia della famiglia; rinchiusa in una casa gaia e tranquilla sì, ma nella cui via non passa nessuno, il cui orizzonte è chiuso da tristi montagne: una fanciulla che non ama, non soffre, non ha pensieri per l’avvenire, non sogni né buoni né cattivi, non amiche, non passatempi, nulla infine, nulla, e dimmi come può essa fare a non annoiarsi. I libri… i giornali… il lavoro… la famiglia! I libri e i giornali sono i miei amici e guai a me senza di loro». (Lettera di Grazia Deledda a Epaminonda Provaglio, Nuoro, 23 febbraio 1892; in Mario Ciusa Romagna (a cura di-), Grazia Deledda, Cagliari, Poligrafica Sarda, 1959, pag. 39).
Il premio Nobel per la letteratura: il primo ad una donna italiana
Ancor giovane e lontana dal successo internazionale, Grazia Deledda fa dire così da Jole nel racconto autobiografico de La casa paterna, una delle novelle contenute nella raccolta Nell’azzurro, pubblicata dall’editore Trevisini nel 1890
«Avevo pubblicato i miei primi lavori, i miei primi bozzetti, a quindici anni: prima di vedere il mio nome stampato, fulgidi sogni, larve dai mantelli di raso, incoronate di fiori, avevano popolato la mia mente: erano i fantasmi della Gloria! Figuratevi dunque il mio dolore, la mia rabbia, la mia delusione quando, nella mia città natia i miei lavori furono accolti in una scoraggiante guisa e mi valsero le risa, la maldicenza, la censura di tutti e specialmente delle donne»
La sua determinazione è onnipresente, immanente alla donna piccina piccina […], ma ardita e coraggiosa come un gigante, ed ancora sono chiare le parole che riserva sempre a Stanis Manca nella lettera dell’8 giugno 1891
«…I primi bozzetti che scrissi, furono sardi, puramente sardi i personaggi, i caratteri ritratti dal vivo, come più e meglio potei nella mia debole fantasia dei sedici anni. Credevo di far onore e piacere ai miei compatrioti e mi aspettavo da loro chissà ché; si figuri il mio dolore, il primo dolore che provai allorché, comparsi alla luce quei racconti, per poco non venni lapidata dai miei conterranei. Si pretese di conoscere i tipi e si volle che i miei personaggi fossero vivi, benché taluni morti decisamente nei bozzetti; e questi eroi offesi, esasperati, non potendo sfidarmi a duello mi coprivano di maldicenza, di ingiurie, di ridicolo, arrivando persino a dire che altri scriveva nell’ombra ed io non facevo che firmare, tanto che il mio povero io, piccola e fragile creatura che non aveva mai fatto male ad alcuno, provò tale dispiacere, tale disillusione, da caderne quasi ammalata» . (Lettera di Grazia Deledda a Stanis Manca, Nuoro, 8 giugno 1891; in Anna Folli (a cura di-), Amore lontano: lettere al gigante biondo, 1891-1909, Milano, Feltrinelli, 2010, pagg. 58-59)
Proprio il distacco dal mondo sardo a Roma troverà modo di rendere ancor più fertile quel periodo eroico dell’infanzia, metabolizzando il paesaggio impresso nella sensibilità e nelle sue memorie. Un vero e proprio stato inventivo della memoria tra senso del dovere e voglia di libertà.
«Accusata di avere, nei miei racconti, sciupato troppo colore e troppa vernice per questi paesaggi, ho voluto rivederli nell’età in cui la fanciullezza non fa più belle della realtà le nostre visioni esterne colorandole del suo divino splendore interno: riveduti dalle impazienti automobili che adesso palpitano nelle vene stradali dell’isola e le riempiono di vita nuova, li ho trovati ancora più belli, nella loro immota e sacra solitudine che vive di sé stessa e pare anzi si rattristi quando viene turbata» (A cavallo, da Il sigillo d’amore)
«Quando cominciai a scrivere – dice la Deledda – non usavo la materia che avevo a portata di mano? Se continuai a usare questo materiale per tutta la vita è perché so quel che ero quando mi formai, legata intimamente alla mia razza: e la mia anima era uguale ad essa; e quando frugai in fondo alle anime dei miei personaggi era nella mia anima che frugavo, e tutte le angustie che io ho raccontato in migliaia di pagine dei miei romanzi e che tanta pena vi hanno fatto, erano i miei dolori, le angosce, i dubbi, le lacrime che io piansi nella mia tragica adolescenza. Questo era il mio segreto!» (Remo Branca, Il segreto di Grazia Deledda, Editrice sarda Fossataro, 1971, pag. 16)
Ancora in Cosima, opera autobiografica di Grazia Deledda pubblicata postuma, il senso di libertà intriso di dovere, di fughe di fantasie e ritorni alla realtà è nelle immedesimazioni con la rondine e la castellana, nei trapassi di cose in persone e persone in cose.
«Si allontanò rapida tra le felci della radura, sfiorandole con le braccia aperte, come una rondine che vola basso all’avvicinarsi del temporale, e tornò poi in cima al dirupo donde si vedeva il mare. Il mare: il grande mistero, la landa di cespugli azzurri, con a riva una siepe di biancospini fioriti; il deserto che la rondine sognava di trasvolare verso le meravigliose regioni del Continente. Se non altro ella avrebbe voluto restare lì sullo spalto dei macigni, come la castellana nel solitario maniero, a guardare l’orizzonte in attesa che una vela vi apparisse con i segni della speranza, o sulla riva balzasse, vestito dei colori del mare, il Principe dell’amore.
Le grida dei giovani nella radura la richiamavano alla realtà: si udivano anche i fischi dei pastori che radunavano il gregge, e ogni voce, ogni suono vibrava nel grande silenzio con un’eco limpida come in una casa di cristallo. Il sole calava dalla parte opposta, sopra le montagne di là della pianura, e già le capre, ancora arrampicate sulle vette, avevano gli occhi rossi come quelli dei falchi. Era tempo di ritornare a casa; e ricordando le sue giornate ancora fanciullesche, rallegrate solo dalle storielle ch’ella raccontava a sé stessa, ella si sentiva al cospetto del mare e sopra i grandi precipizi rossi di tramonto, come la capretta sulla vetta merlata della roccia, che vorrebbe imitare il volo del falco e invece, al fischio del pastore, deve ritornare allo stabbio.»
Dobbiamo ad Antonio Baldini la pubblicazione postuma col titolo di Cosima, quasi Grazia poco dopo la morte di Grazia Deledda, la quale aveva riversato in questa sua ultima fatica tutta la sua autobiografia. Baldini suddivise la pubblicazione in più uscite, nei numeri di settembre e di ottobre 1936 della Nuova Antologia, e fu abile e capace interprete di questa fitta trama di richiami al passato dell’autrice riuscendo nelle note da lui apposte in calce, a ritrovarne puntuale richiamo e ricostruire tutti i rimandi più o meno espliciti alla realtà biografica dell’autrice consacrata dal riconoscimento del premio Nobel.
I tempi successivi non furono certo pieni di altrettanto forti e positivi riconoscimenti da parte della critica italiana, quasi una sorta di nemesi e di ritorno alla perifericità atavicamente immanente nel destino della Deledda: se all’estero la fama internazionale rimase alimentata per un buon lasso di tempo, in Italia l’autrice venne relegata da una grossa parte della critica, con Benedetto Croce in testa, ad una narrativa da lirismo regionale. Gioco ebbe anche proprio l’elemento di forza della capacità narrativa dell’autrice: l’accessibilità al suo linguaggio la rese come nuda e priva di quel manto di verbosità sacrale da riconoscere ad un artista compiutamente maturo, con una sorta di aggravante nella straordinaria quantità di produzione vista come un’inflazione del suo valore artistico, un copia-incolla diremo oggi di situazioni modulari, ripetitive eccessivamente data la limitata geografia narrata. Successivamente, soprattutto a Natalino Sapegno si deve una rivalutazione importante della produzione letteraria e del ruolo artistico di Grazia Deledda, capace di sdoganarla da quella abitudine che l’aveva collocata tra i reperti del Verismo o nell’archivio del Decadentismo.

Eppure Grazia Deledda creò un epos, dove pastori e contadini, padroni e servi vivono in un circolare straordinario altorilievo.
Le sue parole, lette e non a memoria, al discorso per conferimento del premio Nobel 1926 sono la chiusura che pensiamo essere la migliore per descrivere Grazia Deledda che, finalmente, può descrivere direttamente sé, in prima persona:
«Sono nata in Sardegna. La mia famiglia, composta di gente savia ma anche di violenti e di artisti produttivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca; ma quando cominciai a scrivere, a tredici anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce: ‘se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se fa per la terza volta, lascialo in pace perché è un poeta’. Senza vanità anche a me è capitato così. Avevo un irresistibile miraggio del mondo, soprattutto di Roma. E a Roma, sotto il fulgore della giovinezza, mi costruìi una casa mia dove vivo tranquilla col mio compagno di vita ad ascoltare le ardenti parole dei miei figli giovani. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino. Ma grande sopra ogni fortuna la fede nella vita e in Dio. Grazia Deledda.»
Nella sezione https://www.saidinitaly.it/category/saidin/said-in-poesia-e-lirica/ riporteremo brani di Grazia Deledda da condividere come lettura con voi.

 SAID IN ITALY Il pensiero Made in Italy… …nelle parole della sua gente
SAID IN ITALY Il pensiero Made in Italy… …nelle parole della sua gente